 La chiesa di Sant’Orsola a Chiaia ha ospitato l’Ensemble Labirinto Armonico, formato da Pierluigi Mencattini, Egidio Mastrominico e Giovanni Rota (violini barocchi) e Maurizio Maffezzoli (organo).
La chiesa di Sant’Orsola a Chiaia ha ospitato l’Ensemble Labirinto Armonico, formato da Pierluigi Mencattini, Egidio Mastrominico e Giovanni Rota (violini barocchi) e Maurizio Maffezzoli (organo).
Il concerto, proposto nell’ambito della XVIII edizione di Convivio Armonico di Area Arte, per il ciclo “Suoni nei luoghi sacri”, si prefiggeva di riportare alla luce una serie di validissimi autori, molti dei quali attivi a Napoli, oggi praticamente sconosciuti.
Si partiva da Giuseppe Antonio Avitrano (1670-1756), violinista dell’orchestra della corte di Napoli dal 1690, con la Sonata I “L’Aurora”, tratta dalle 12 sonate a quattro, per 3 violini e basso continuo, op. 3.
Pubblicate a Napoli nel 1713, furono dedicate a Carlo Pacecco Carafa, e ognuna era accompagnata da un nome di una persona o di una famiglia imparentata con i Carafa.
Il successivo Ballo di Mantova per organo, portava alla ribalta il romano Giovan Battista Ferrini (ca. 1601-1674), noto ai suoi tempi come “Giovan Battista della spinetta”.
Lodato sia da Athanasius Kircher nella Musurgia universalis che da Giuseppe Ottavio Pitoni nella Guida armonica, fu uno dei migliori autori di musica per tastiera nel periodo che precedette l’avvento di Pasquini.
Toccava quindi a Gregorio Strozzi (1615 – 1687), con la Mascara sonata e ballata da più cavalieri Napolitani nel Regio Palazzo, appartenente alla raccolta Capricci da sonare cembali et organi op. 4 (Napoli, 1687).
Nato a San Severino Lucano, Strozzi studiò prima con Frescobaldi e poi, a Napoli, con Giovanni Maria Sabino, acquisendo uno stile influenzato dai suoi maestri, ma che si avvaleva anche di sonorità arabe.
Partenopeo era invece Angelo Ragazzi (1680-1750) virtuoso del violino, allievo di Gian Carlo Cailò presso il Conservatorio di Santa Maria di Loreto, che visse fra le corti di Napoli e Vienna, autore della Sonata a quattro op. I n. 1 in sol maggiore (dalle 12 sonate a quattro op.1, raccolta pubblicata a Roma nel 1736).
Quasi niente si sa , invece, di Bernardo Storace (1637-1707), tranne che ricoprì il ruolo di vice maestro di cappella presso il Senato della città di Messina.
Della sua produzione è sopravvissuta solo la Selva di varie compositioni d’intavolatura per cimbalo et organo (Venezia, 1664), contenente anche la Toccata in sol che abbiamo ascoltato.
Il programma proseguiva con le Sonate n. 3 e n. 6 di Fedele Fenaroli (1730-1818), abruzzese trapiantato a Napoli, dove studiò probabilmente con Francesco Durante e Pietro Antonio Gallo e, a sua volta, ebbe allievi del calibro di Zingarelli, Cimarosa e Mercadante.
L’attività di docente finì per mettere in ombra la sua produzione, che comprendeva anche pregevole musica per strumenti a tastiera, come quella proposta al concerto.
Dopo un’ altra sonata di Giuseppe Antonio Avitrano, “L’Aragona”, sempre dall’op.3, venivano eseguiti gli ultimi due pezzi, una Pastorale in fa a organo solo di Antonio Maria Costantini (1787 – 1854) e la Sonata a tre violini e organo di Gian Carlo Cailò (1659- 1722).
Nel primo caso avevamo di fronte un francescano marchigiano, nato a Monte Santo (Potenza Picena dal 1862) che, dopo essere stato allievo di Niccolò Zingarelli a Napoli, si spostò ad Assisi, dove studiò con padre Antonio Maria Amone e fu nominato organista della Basilica di San Francesco nel 1828, ruolo che ricoprì anche nella Basilica di S. Antonio a Padova dal 1834 al 1853.
Riguardo a Gian Carlo Cailò, nacque presumibilmente a Roma, dove fu attivo come violinista, trasferendosi poi a Napoli al seguito di Alessandro Scarlatti.
Nella città partenopea si distinse sia come solista nella Reale Cappella e nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, che in qualità di docente, al Conservatorio di Santa Maria di Loreto e al Conservatorio della Pietà de’ Turchini, avendo come allievi il già citato Ragazzi, Nicola Fiorenza ed i violoncellisti Francesco Paolo Scipriani e Francesco Alborea.
Nel complesso un programma di estremo interesse, al quale i violinisti Pierluigi Mencattini, Egidio Mastrominico e Giovanni Rota, e l’organista Maurizio Maffezzoli, hanno fornito il loro prestigioso apporto come singoli interpreti (in particolare Maffezzoli, impegnato durante l’intero concerto, come basso continuo e come solista), evidenziando inoltre un notevole affiatamento.
Pubblico molto numeroso e favorevolmente impressionato da una serie di brani di rara proposizione, concepiti da autori misconosciuti che meriterebbero ulteriori approfondimenti.
Il nostro augurio conclusivo è quindi quello di poter ascoltare quanto prima altri pezzi di compositori, caduti spesso inspiegabilmente nel dimenticatoio, che hanno fatto la storia della musica barocca napoletana.
-
Articoli recenti
- Sabato 6 novembre Asolo Musica inizia la seconda parte con il concerto del Quartetto di Venezia e del flautista Massimo Mercelli
- Sabato 6 novembre parte a Salerno la XIII edizione del Festival Internazionale PianoSolo nell’ambito di Salerno Classica
- Domenica 7 novembre la XXIV stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini si apre con “La Petite Écurie”
- Sabato 6 novembre la rassegna di Dissonanzen “Bagliori” propone il duo Ceccarelli-Trovalusci
- Domenica 7 novembre al Teatro dell’Antoniano di Bologna riprende Baby Bofe’ con “Pierino e il lupo” di Prokofiev
Commenti recenti
Fabrizio De Rossi Re su Venerdì 29 ottobre ad Ascoli P… Fabrizio De Rossi Re su “Vox in Bestia – G… 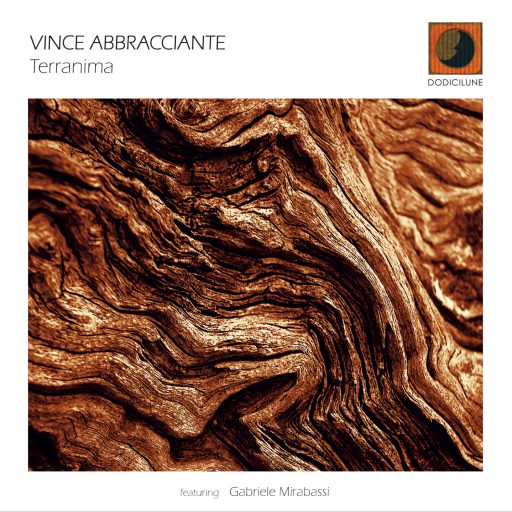
Santuario – Ja… su Sincretico, interessante propo… Fabrizio De Rossi Re su Mercoledì 26 maggio a Radio Va… Fabrizio De Rossi Re su Su RAI Radio 3 Suite dal 10 al… Archivi
- novembre 2021
- ottobre 2021
- settembre 2021
- agosto 2021
- luglio 2021
- giugno 2021
- Maggio 2021
- aprile 2021
- marzo 2021
- febbraio 2021
- gennaio 2021
- dicembre 2020
- novembre 2020
- ottobre 2020
- settembre 2020
- agosto 2020
- luglio 2020
- giugno 2020
- Maggio 2020
- aprile 2020
- marzo 2020
- febbraio 2020
- gennaio 2020
- dicembre 2019
- novembre 2019
- ottobre 2019
- settembre 2019
- agosto 2019
- luglio 2019
- giugno 2019
- Maggio 2019
- aprile 2019
- marzo 2019
- febbraio 2019
- gennaio 2019
- dicembre 2018
- novembre 2018
- ottobre 2018
- settembre 2018
- agosto 2018
- luglio 2018
- giugno 2018
- Maggio 2018
- aprile 2018
- marzo 2018
- febbraio 2018
- gennaio 2018
- dicembre 2017
- novembre 2017
- ottobre 2017
- settembre 2017
- agosto 2017
- luglio 2017
- giugno 2017
- Maggio 2017
- aprile 2017
- marzo 2017
- febbraio 2017
- gennaio 2017
- dicembre 2016
- novembre 2016
- ottobre 2016
- settembre 2016
- agosto 2016
- luglio 2016
- giugno 2016
- Maggio 2016
- aprile 2016
- marzo 2016
- febbraio 2016
- gennaio 2016
- dicembre 2015
- novembre 2015
- ottobre 2015
- settembre 2015
- agosto 2015
- luglio 2015
- giugno 2015
- Maggio 2015
- aprile 2015
- marzo 2015
- febbraio 2015
- gennaio 2015
- dicembre 2014
- novembre 2014
- ottobre 2014
- settembre 2014
- agosto 2014
- luglio 2014
- giugno 2014
- Maggio 2014
- aprile 2014
- marzo 2014
- febbraio 2014
- gennaio 2014
- dicembre 2013
- novembre 2013
- ottobre 2013
- settembre 2013
- agosto 2013
- luglio 2013
- giugno 2013
- Maggio 2013
- aprile 2013
- marzo 2013
- febbraio 2013
- gennaio 2013
- dicembre 2012
- novembre 2012
- ottobre 2012
- settembre 2012
- agosto 2012
- luglio 2012
- giugno 2012
- Maggio 2012
- aprile 2012
- marzo 2012
- febbraio 2012
- gennaio 2012
- dicembre 2011
- novembre 2011
- ottobre 2011
- settembre 2011
- agosto 2011
- luglio 2011
- giugno 2011
- Maggio 2011
- aprile 2011
- marzo 2011
- febbraio 2011
Categorie
Meta
